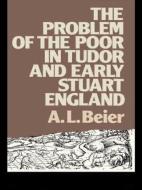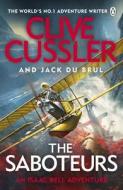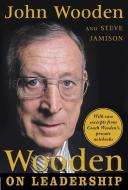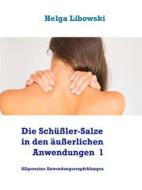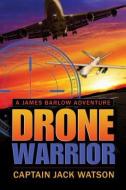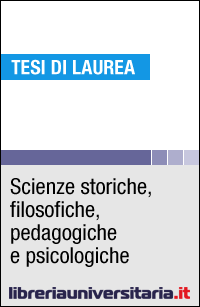
Limiti e tutele all'obiezione di coscienza in ambito sanitario
- Tipologia:
Diploma di laurea
- Anno accademico:
2017/2018
- Relatore:
- Prof. massimo Reichlin
- Università:
università vita e salute san raffaele
- Facoltà:
Filosofia
- Corso:
Filosofia
- Cattedra:
bioetica
- Lingua:
- Italiano
- Pagine:
- 64
- Formato:
- Protezione:
- DRM Adobe
- Dimensione:
- 2.17 Mb
Descrizione Limiti e tutele all'obiezione di coscienza in ambito sanitario
In questo elaborato si sostiene la necessità di tutelare l’obiezione di coscienza in ambito sanitario. Poiché la radice di ogni rifiuto genuino è la coscienza, il primo capitolo inizia con un resoconto delle varie definizioni che di essa sono state date nella storia. A partire dalla conscientia di Cicerone e Quintiliano, passando per la sinderesi medievale, si giunge, infine, alla concezione di Sulmasy, che lega la coscienza a un profondo impegno per la moralità. Viene, poi, chiarito che cosa sia l’obiezione di coscienza in generale, secondo le prospettive di Rawls, Arendt e Thoreau. Attraverso il pensiero degli ultimi due, viene tracciata una distinzione fra obiezione di coscienza e disobbedienza civile. Essa risiede principalmente nel carattere individuale, non necessariamente politico della prima e nel carattere collettivo e necessariamente politico della seconda. In seguito, vengono esaminate le questioni dell’aborto e della sospensione dei trattamenti in malati terminali o in stato vegetativo persistente. Anche se si tratta di pratiche legittime, non se ne può affermare la giustezza in assoluto. Infatti, è possibile portare argomenti favorevoli ma anche contrari. Pertanto, la legge non può imporle, ma deve garantire l’esenzione. Tale diritto viene sancito nelle leggi italiane, francesi, spagnole e inglesi, seppur con delle differenze nei trattamenti considerati. Le tesi normative sostenute nel secondo capitolo vengono giustificate a partire dalla concezione di Sulmasy sulla coscienza, presentata nel primo paragrafo. Dall’impegno per la moralità, radicato in ogni persona, seguono il rispetto per l’integrità morale e la tolleranza. Lo confermano le tesi di Wicclair e Brownlee, la quale riformula tale affermazione nello “humanistic principle”. Tuttavia, quest’ultimo viene riferito alla disobbedienza civile, mentre l’obiezione di coscienza viene ritenuta “non coscienziosa”. In realtà, viene mostrato come, per il suo carattere individuale e non necessariamente politico, la seconda sia più legata alla coscienza rispetto alla prima. Il pluralismo, poi, costituisce un secondo fondamento per la tolleranza. Esso viene richiamato per contestare la posizione di Giubilini, che impiega il relativismo morale come argomento contro le concezioni basate sulla tolleranza e l’integrità. Se ci si appella, inoltre, al valore dell’autonomia, si riesce a mostrare come una società tollerante sia altamente desiderabile. Un altro principio, spesso richiamato dagli oppositori dell’obiezione, è quello della libertà di coscienza. Su di esso fondano le loro critiche Lalli e Flamigni, i quali ritengono che l’obiezione di coscienza generi un conflitto insanabile fra la coscienza del medico e quella del paziente, fra l’individuo e lo stato. Viene mostrato come, in realtà, tale conflitto sia risolvibile senza dover necessariamente sacrificare né la coscienza del paziente né l’autorità della legge. Il terzo capitolo si occupa, invece, dei limiti a un esercizio assoluto della coscienza da parte del personale sanitario. Essi sono necessari al fine di evitare una possibile “obiezione a cascata”, la quale avrebbe come effetto una paralisi del sistema. Una delle cause dell’inefficienza nell’erogazione dei servizi è stata individuata negli obiettori di comodo. Si è cercato, quindi, di determinare un criterio per distinguere questi ultimi dagli obiettori “autentici”. Tale distinzione non può essere dimostrata tramite il tradizionale interrogatorio, data la natura intima e insondabile della coscienza. Risultano adeguate, perciò, delle soluzioni che prescindano dalle ragioni dell’obiezione. La prima di queste consiste nell’introduzione di penalità, per scoraggiare comportamenti motivati dalla pura convenienza. La seconda è costituita da una prova di coerenza “a posteriori”. Entrambe sfruttano il valore testimoniale che ha la condotta di un individuo in relazione alle sue credenze più profonde. Infine, viene trattata la questione della complicità morale. Essa può essere percepita da un obiettore che faciliti un trasferimento o che dia informazioni utili al paziente su come ottenere il trattamento che egli ritiene moralmente sbagliato. A prescindere dal grado di responsabilità, se ne conclude che è giusto che egli si occupi personalmente di queste procedure o che, in alternativa, deleghi a un collega.